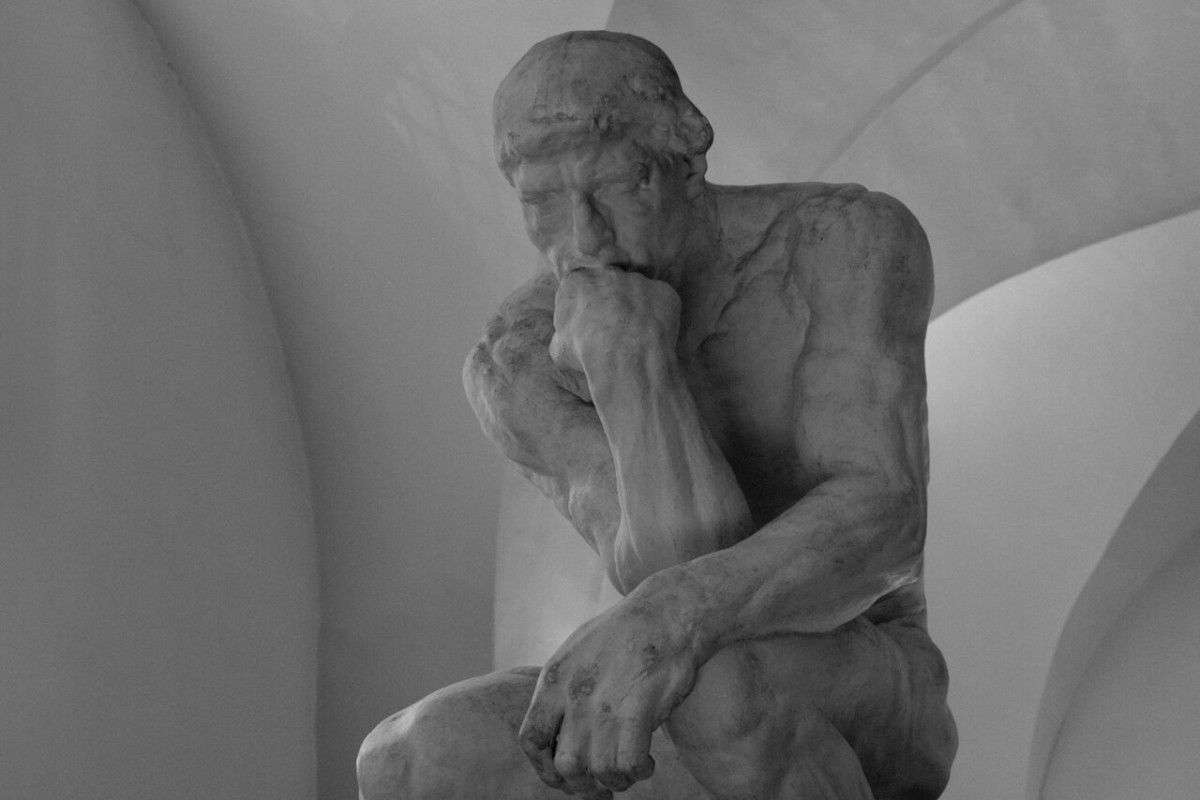L’intelligenza artificiale cambia il modo in cui lavoriamo e apprendiamo, ma nasconde effetti non trascurabili sulla mente umana. Ricerche recenti mostrano come l’uso di strumenti basati su IA, come ChatGPT, possa indebolire l’attività cerebrale legata alla creatività e alla concentrazione, mettendo a rischio alcune capacità cognitive fondamentali.
Evidenze scientifiche sul calo di attività cerebrale durante l’uso di intelligenza artificiale
Uno studio condotto al Massachusetts Institute of Technology ha monitorato studenti durante la scrittura usando elettroencefalogrammi. Chi si affidava all’intelligenza artificiale per generare testi mostrava un’attenuazione significativa dell’attività nelle aree deputate alla creatività e all’attenzione. Questo segnale neurologico si rifletteva anche nella difficoltà successiva a ricordare o citare correttamente i contenuti appena prodotti con l’assistenza virtuale. L’esperimento evidenzia come la delega al sistema generativo non sia neutra sul piano cognitivo.
In parallelo, l’Economist ha raccolto elementi da varie ricerche in corso sulle implicazioni del ricorso continuo all’IA. Questi dati mettono in discussione la salute mentale e la capacità critica degli utenti, segnalando la necessità di approfondimenti e monitoraggi continui.
Lavoro “meccanico” e perdita di pensiero critico: il quadro emerso in ambienti lavorativi e scolastici
Un’indagine di Microsoft su oltre 300 professionisti ha rivelato che l’impiego di AI come ChatGPT e Copilot spesso trasforma i compiti in processi “meccanici”. Questo modo di operare riduce il coinvolgimento critico nelle attività e rischia di abbassare la qualità del ragionamento. Lo studio britannico del professor Michael Gerlich conferma questa tendenza: utenti più dipendenti dalla tecnologia hanno raggiunto punteggi inferiori nei test di pensiero critico.
Gli insegnanti segnalano un aumento delle difficoltà scolastiche riconducibili proprio all’uso massiccio di chatbot, come ha dichiarato Gerlich. Questi segnali portano a riflettere sul ruolo delle tecnologie generative nell’insegnamento e sulla necessità di limitare o meglio guidarne l’impiego nelle aule.
Cognitive Offloading: quando delegare il pensiero all’IA diventa un problema
Il fenomeno del cognitive offloading indica la tendenza a spostare su strumenti esterni compiti mentali impegnativi. Lo psicologo Evan Risko, dall’Università di Waterloo, sottolinea che con l’intelligenza artificiale questo meccanismo riguarda attività complesse come scrivere testi o risolvere problemi, non solo semplici calcoli o annotazioni. Questa esternalizzazione prolungata fa perdere abilità cognitive fondamentali.
Il rischio principale è la formazione di una spirale negativa. Michael Gerlich parla di un ciclo di retroazione dove chi pensa meno si affida sempre più all’IA, riducendo ulteriormente la capacità critica e creativa. Alcuni partecipanti agli studi descrivono una forte dipendenza dall’IA, come uno studente che ha ammesso di non saper più affrontare da solo problemi affrontati prima con facilità.
Impatto sull’originalità delle idee: esperimenti e esempi concreti
Non solo il pensiero critico, ma anche la creatività subisce gli effetti dell’uso eccessivo dell’intelligenza artificiale. In un test svolto all’Università di Toronto, coloro che hanno ricevuto molte proposte da chatbot hanno prodotto risposte meno originali rispetto a chi ha lavorato senza assistenza tecnologica.
Ad esempio, di fronte alla domanda su come riutilizzare un paio di pantaloni, l’IA ha suggerito un’idea semplice e poco innovativa come uno spaventapasseri. Un partecipante umano ha proposto invece di riempire le tasche con noccioline per trasformarli in una mangiatoia per uccelli, mostrando un’inedita sensibilità e capacità inventiva. Questi risultati mettono in luce come l’uso indiscriminato di chatbot possa limitare la diversità e l’unicità delle soluzioni creative.
Strategie per un uso consapevole dell’intelligenza artificiale in ambito cognitivo
Nonostante i limiti, alcuni ricercatori vedono nella IA un potenziale ausilio da gestire con attenzione. L’idea è quella di trasformare questi strumenti in assistenti critici, che supportino il ragionamento anziché sostituirlo. In questa prospettiva si suggeriscono chatbot “maieutici”, cioè capaci di porre domande per stimolare la riflessione e non semplicemente fornire risposte dirette.
L’Economist riporta che un simile approccio, vicino al metodo socratico, potrebbe salvaguardare le abilità mentali evitando la dipendenza passiva dagli algoritmi. Questo orientamento invita a ripensare il rapporto tra intelligenza umana e artificiale, favorendo un dialogo più interattivo e meno delegante.
Una sfida aperta per aziende, educatori e utenti nell’era della tecnologia generativa
Il cervello umano mantiene un ruolo fondamentale, anche se la diffusione degli strumenti basati su IA cresce rapidamente in ambito professionale e formativo. La giovinezza di queste tecnologie non impedisce di interrogarsi sui limiti e sui costi cognitivi che possono comportare per chi le adotta quotidianamente.
Esperti e operatori chiamano a riflettere sulla necessità di bilanciare vantaggi e svantaggi, evitando di compromettere la capacità di pensare e creare degli individui. Il confronto con l’IA non riguarda solo la tecnologia, ma l’equilibrio d’uso che ogni persona o istituzione dovrà trovare in un futuro ormai alle porte.
Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2025 da Elisa Romano