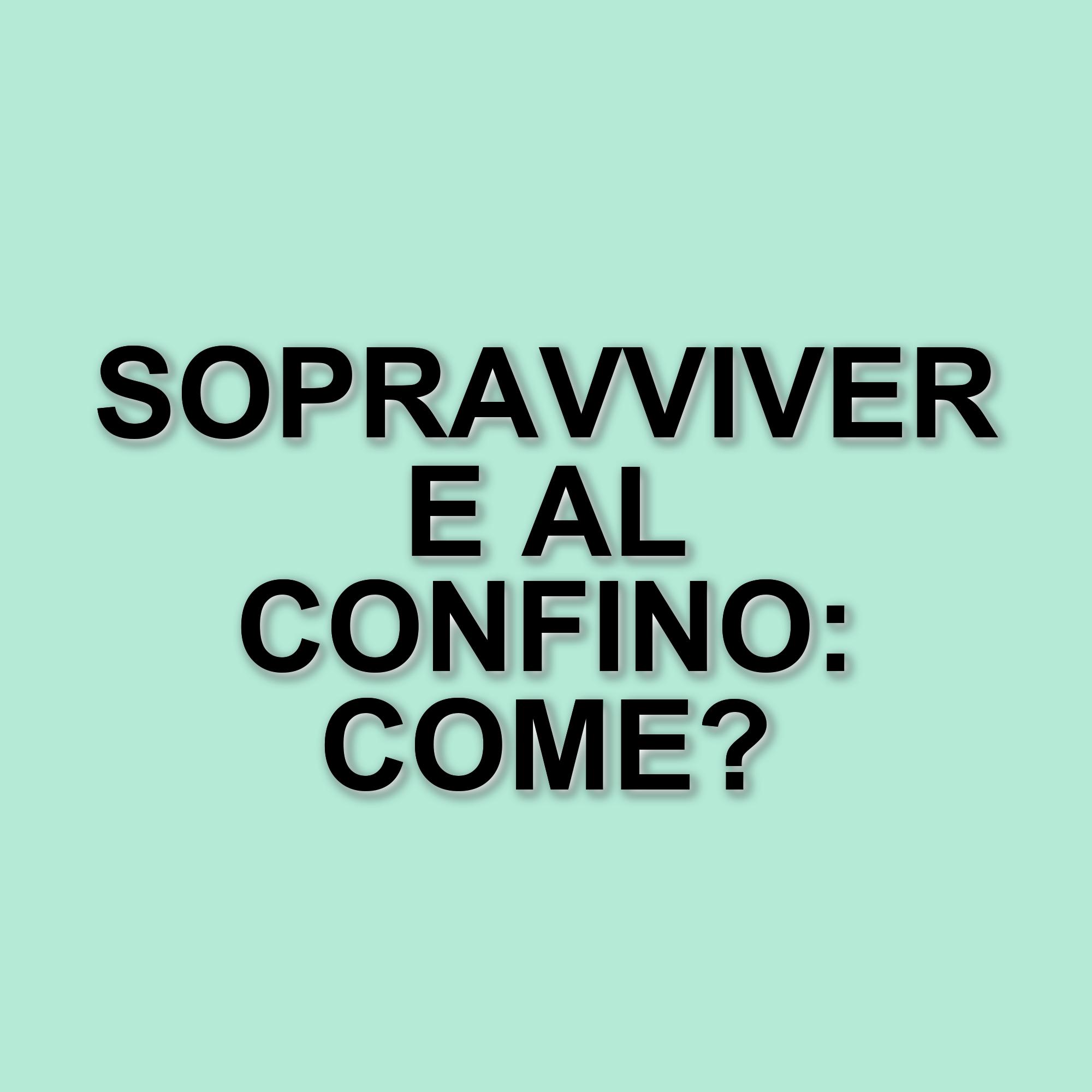La storia dei confinati politici a Ventotene offre uno spaccato significativo della repressione fascista in Italia. Tra il 1926 e il 1943, l’isola divenne un luogo di detenzione per circa tremila oppositori del regime, tra cui comunisti, anarchici e socialisti. Questo articolo esplora la vita quotidiana di questi individui, le condizioni di vita e il contesto storico che ha portato alla loro detenzione.
La condizione dei confinati politici
Contrariamente a quanto affermato in passato, la vita dei confinati politici a Ventotene non era affatto una “villeggiatura”. Sotto il regime fascista, i detenuti vivevano in condizioni estremamente difficili, sottoposti a rigide regole e sorveglianza costante. Tra i più noti, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, autori del Manifesto di Ventotene, trascorrevano le loro giornate segregati in cameroni, con orari di accesso limitati.
I confinati non avevano la possibilità di interagire con la popolazione locale, se non per brevi momenti durante le loro visite ai negozi, dove potevano acquistare beni essenziali. Tuttavia, il loro stipendio mensile era di sole cinque lire, insufficienti per soddisfare anche i bisogni più basilari. I documenti personali venivano sequestrati all’arrivo, e i detenuti ricevevano solo un “libretto rosso” che ne regolava la permanenza sull’isola.
Il cibo era scarso e di bassa qualità, e le opportunità di integrare la dieta coltivando orti o allevando animali erano limitate. Un esempio emblematico è quello di Arturo Colombi, un comunista che, durante il confino, passò da un peso di 80 chili a soli 55. Giuseppe Di Vittorio, futuro segretario della CGIL, si occupava dell’unica mucca presente, il cui latte era destinato ai tubercolotici, che avevano un’area riservata.
Ogni giorno, i confinati erano sottoposti a due o tre appelli, e i più considerati pericolosi dal regime erano seguiti da un milite. Era vietato ascoltare la radio e la corrispondenza era limitata a una lettera settimanale, sottoposta a censura. Il Manifesto di Ventotene, redatto clandestinamente, fu scritto su cartine per sigarette e portato sulla terraferma da Ursula Hirschmann, moglie di Eugenio Colorni, ucciso dai fascisti nel 1944.
Il contesto storico del confino
Il confino di polizia fu introdotto nel 1926 come parte delle leggi fascistissime, permettendo alle autorità di pubblica sicurezza di isolare individui ritenuti pericolosi per lo Stato. Questo provvedimento poteva durare da uno a cinque anni e veniva applicato senza alcun intervento della magistratura. Molti dei confinati a Ventotene avevano già scontato pene per atti di opposizione al regime, ma il confino poteva essere imposto anche per trasgressioni minori, come il racconto di una barzelletta su Benito Mussolini.
L’isola di Ventotene divenne la principale colonia di confino dopo la fuga di alcuni oppositori da Lipari nel 1930. La scelta di Ventotene, con le sue coste impervie e la sua posizione isolata, si rivelò strategica per il regime fascista. Nel 1939, con la chiusura della colonia di Ponza, Ventotene assunse un ruolo ancora più centrale, ospitando i detenuti considerati più pericolosi, tra cui Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica.
Tra i confinati vi erano figure che avrebbero avuto ruoli di rilievo nella storia politica italiana, come Luigi Longo e Pietro Secchia, oltre a Umberto Terracini, che in seguito presiedette l’Assemblea Costituente. Questi individui, una volta liberati nel 1943, sarebbero diventati i leader del Partito Comunista Italiano, contribuendo a plasmare il futuro politico del paese.
L’eredità culturale di Ventotene
Ventotene non fu solo un luogo di detenzione, ma anche un centro di formazione politica e culturale. Gli ospiti dell’isola organizzarono attività di studio e discussione, creando una biblioteca clandestina e promuovendo corsi di formazione. Oltre al Manifesto di Spinelli e Rossi, venne redatto anche un importante testo di Pietro Grifone, “Il capitale finanziario in Italia”, pubblicato nel 1971.
I reduci della guerra di Spagna, presenti sull’isola, impartivano lezioni di tattica militare, che si sarebbero rivelate utili durante la Resistenza. Questo ambiente di scambio culturale e politico ha portato Ventotene a essere definita “l’università del confino”, un luogo dove le idee di libertà e giustizia si sono consolidate, nonostante le dure condizioni di vita.
Dopo la caduta del regime fascista, il 28 luglio 1943, Ventotene divenne teatro di un episodio significativo: Mussolini, arrestato tre giorni prima, doveva essere relegato sull’isola, ma il commissario della colonia si oppose, temendo per la sicurezza dell’ex dittatore. Questo episodio evidenziò il clima di tensione e la determinazione dei confinati, che avevano vissuto anni di repressione e privazioni.
La storia di Ventotene e dei suoi confinati rimane un capitolo fondamentale nella memoria collettiva italiana, testimoniando la resistenza contro la dittatura e l’importanza della libertà di espressione.
Ultimo aggiornamento il 5 Maggio 2025 da Matteo Bernardi