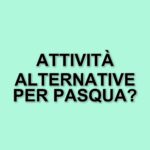In Italia, la situazione economica dei minori è allarmante. Secondo recenti dati, il 12,5% dei ragazzi e delle ragazze sotto i 18 anni vive in povertà assoluta, il che equivale a oltre 1,2 milioni di giovani che si trovano in famiglie incapaci di coprire le spese minime per uno stile di vita dignitoso. Di questi, circa mezzo milione risiede nel Mezzogiorno, dove il disagio economico si traduce spesso in un significativo divario educativo.
Il diritto all’istruzione e le sfide della povertà educativa
Contrastare la povertà educativa significa riconoscere il diritto di ogni bambino e bambina ad apprendere e sviluppare le proprie competenze e talenti. È fondamentale garantire un accesso a un’offerta educativa di qualità, che includa opportunità di partecipazione culturale e sociale. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un impegno sistematico e coordinato, che preveda politiche efficaci per i minori.
La povertà educativa si manifesta in vari modi. Un bambino che ha difficoltà scolastiche e non riceve il supporto necessario, che non ha mai praticato sport o visto un film al cinema, o che vive in un ambiente familiare privo di libri e giochi adatti alla sua età, rappresenta un esempio emblematico di questo fenomeno. Questa situazione non è solo una questione di accesso all’istruzione, ma implica una mancanza di opportunità educative in senso più ampio, che include anche il diritto al gioco e alle attività sportive.
Leggi anche:
Dimensioni della povertà educativa in Italia
La povertà educativa non riguarda solo l’accesso all’istruzione, ma abbraccia diverse dimensioni, tra cui opportunità culturali, relazioni sociali e attività formative. In Italia, la percentuale di minori in povertà assoluta è preoccupante. Le famiglie con minori in condizioni di povertà assoluta sono quasi 748mila, e negli ultimi anni hanno dovuto affrontare l’aumento dei prezzi di beni e servizi essenziali per la prima infanzia.
Nel 2023, la povertà alimentare ha ripreso a crescere, come evidenziato dai dati preliminari dell’Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie. Questo segna un’inversione rispetto a una tendenza di miglioramento che si era mantenuta anche durante la pandemia, grazie a misure straordinarie adottate per affrontare l’emergenza sanitaria.
La povertà alimentare e le sue implicazioni
La povertà alimentare è un fenomeno complesso che richiede un’analisi approfondita di vari fattori, alcuni dei quali non facilmente quantificabili. Per stimare la diffusione di questo problema, si utilizzano indicatori come l’impossibilità di consumare un pasto completo ogni due giorni e la mancanza di occasioni per socializzare attorno a un pasto. Si stima che il 10,5% della popolazione, circa 5,3 milioni di persone, non abbia accesso a cibo adeguato o non partecipi a eventi sociali legati alla condivisione del cibo.
Attualmente, in Italia manca una politica strutturata e efficace per affrontare la povertà alimentare. Per colmare questa lacuna, è necessaria una visione chiara del problema e una strategia a lungo termine che integri le politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Tuttavia, gli attuali programmi nazionali e locali si concentrano principalmente sulle necessità alimentari delle persone in difficoltà economica, senza affrontare in modo coerente le cause profonde del problema.
Un approccio di filiera alla povertà alimentare
L’approccio prevalente per affrontare la povertà alimentare in Italia è quello “di filiera”, che si concentra sulla distribuzione di cibo attraverso canali specifici come acquisti governativi, eccedenze alimentari e donazioni da privati e imprese. Questo metodo, sebbene utile, non risolve le problematiche strutturali legate alla povertà alimentare, che richiedono risposte più ampie e sistematiche.
È evidente che la situazione attuale richiede un intervento deciso e coordinato per garantire a tutti i minori in Italia le opportunità educative e alimentari necessarie per crescere e svilupparsi in modo sano e completo.