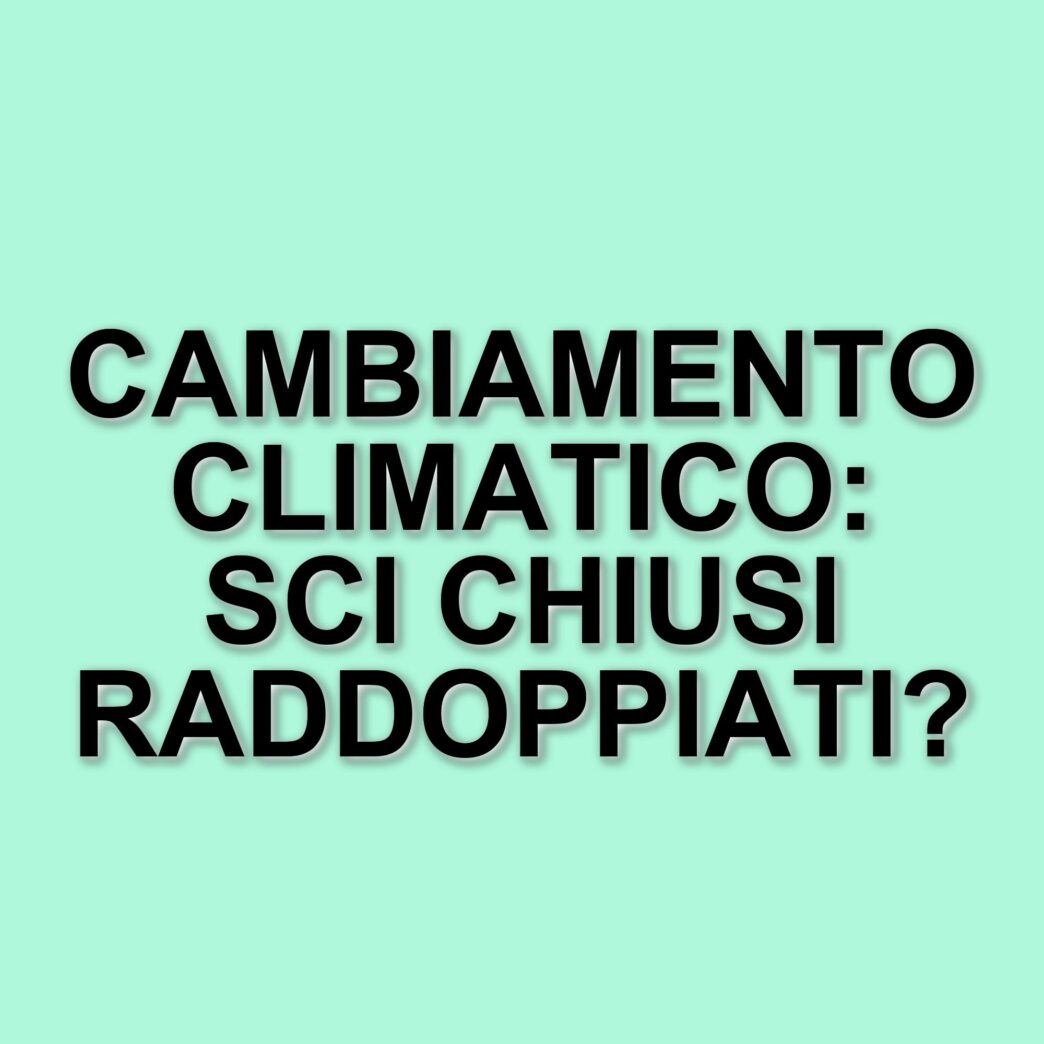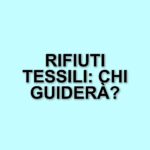Il cambiamento climatico sta colpendo duramente le montagne italiane, come evidenziato nel report di Legambiente “Nevediversa 2025 – Una nuova montagna è possibile”. Secondo il documento, il numero di impianti sciistici non più operativi è raddoppiato dal 2020, passando da 132 a 265. Le regioni più colpite includono il Piemonte, la Lombardia, l’Abruzzo e il Veneto, tutte segnate da un evidente calo delle nevicate e da temperature in aumento. Questo scenario mette in discussione non solo l’economia legata al turismo invernale, ma anche la sostenibilità delle comunità montane.
L’aumento degli impianti di innevamento artificiale
Nonostante la chiusura di numerosi impianti, il numero di bacini per l’innevamento artificiale è in crescita. Attualmente, in Italia si contano 165 bacini, per una superficie complessiva di circa 1.896.317 mq. Il Trentino-Alto Adige è in cima alla lista con 60 bacini, seguito da Lombardia e Piemonte, entrambe con 23 bacini. La Valle d’Aosta, pur avendo solo 14 bacini, si distingue per la sua estensione, raggiungendo ben 871.832 mq. Questi bacini rappresentano una risposta necessaria alla diminuzione della neve naturale, ma sollevano interrogativi sulla loro sostenibilità e sull’impatto ambientale.
La situazione internazionale: un problema globale
La crisi non si limita all’Italia. Secondo Mountain Wilderness Francia, nel 2024 sono stati censiti 101 impianti abbandonati sulle Alpi francesi, mentre in Svizzera oltre 55 skilift e funivie risultano dismessi da anni. Questo fenomeno evidenzia un problema più ampio, che coinvolge non solo le Alpi italiane, ma anche le montagne di altri paesi. La chiusura degli impianti non è solo una questione economica, ma anche una questione di identità culturale e sociale per le comunità montane.
Leggi anche:
Il caso emblematico della bidonvia di Pian dei Fiacconi
Legambiente ha scelto di evidenziare la bidonvia di Pian dei Fiacconi, situata sul versante nord della Marmolada, come esempio emblematico della crisi. Questo impianto, chiuso nel 2019, è stato distrutto da una valanga nel dicembre 2020, lasciando dietro di sé una struttura abbandonata che ha un impatto ambientale significativo in un’area riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. La situazione della Marmolada è complicata ulteriormente da contese tra le regioni, creando incertezze che ostacolano gli investimenti e lo sviluppo.
La posizione di Anef e le sfide del settore
Valeria Ghezzi, presidente di Anef, l’associazione nazionale degli esercenti funiviari, ha risposto alle preoccupazioni espresse da Legambiente, sottolineando che non tutti gli impianti dismessi sono realmente in crisi. Alcuni possono riprendere le operazioni dopo un anno di inattività. Ghezzi ha anche evidenziato che la Marmolada è attualmente in una fase di stallo, il che rende difficile qualsiasi impegno imprenditoriale. La realtà, secondo Anef, è che molte località alpine stanno affrontando la stagione invernale con successo, grazie a una gestione attenta e alla programmazione dell’innevamento.
Investimenti nell’innevamento artificiale
Negli ultimi anni, l’innevamento artificiale è diventato una spesa necessaria per la sopravvivenza delle stazioni sciistiche. Legambiente ha riportato che, a metà febbraio 2025, il bellunese ha speso 2 milioni di euro per l’innevamento artificiale dall’inizio della stagione. Al Sestriere, in Piemonte, la spesa ha superato i 10 milioni in quattro anni. Questi investimenti sono cruciali per garantire la continuità delle attività turistiche e sportive, ma sollevano interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine.
La neve artificiale come necessità
Ghezzi ha affermato che la neve artificiale non è un’alterazione della natura, ma una necessità per garantire la sopravvivenza delle comunità montane. Negli ultimi decenni, gli operatori del settore hanno imparato a gestire la mancanza di neve naturale, investendo in tecnologie più efficienti e sostenibili. La neve artificiale, prodotta esclusivamente con acqua e aria, è un modo per garantire la continuità delle attività turistiche e per sostenere l’economia locale.
Un futuro incerto per le montagne italiane
Le previsioni per i prossimi anni indicano inverni più caldi e una riduzione delle nevicate. I dati della Fondazione Cima mostrano un grave deficit nevoso, con una riduzione del 71% sulle Alpi e del 94% sugli Appennini. Ghezzi ha sottolineato che gli impiantisti sono pronti a collaborare per affrontare gli effetti del cambiamento climatico, ma la produzione di neve artificiale è diventata un obbligo per garantire la sopravvivenza delle valli montane.
Innovazione e sostenibilità nel settore
La neve artificiale è prodotta attraverso un processo che non inquina e non spreca acqua, trasformando l’acqua in cristalli di neve. I nuovi mezzi battipista utilizzano tecnologie avanzate per misurare la quantità di neve da produrre, riducendo gli sprechi e utilizzando energia rinnovabile. Negli ultimi 15 anni, i progressi tecnologici hanno migliorato notevolmente l’efficienza nella produzione di neve, garantendo un futuro più sostenibile per le stazioni sciistiche.
L’importanza delle comunità montane
Le aree sciistiche non sono solo impianti di risalita, ma rappresentano un ecosistema economico complesso che sostiene le comunità montane. Il turismo invernale è fondamentale per questi territori, creando posti di lavoro e opportunità economiche. La neve artificiale gioca un ruolo cruciale nel sostenere questa economia, contribuendo a mantenere viva l’identità culturale e sociale delle montagne italiane.
La situazione attuale richiede un ripensamento delle strategie per affrontare la crisi climatica e garantire un futuro sostenibile per le montagne italiane.