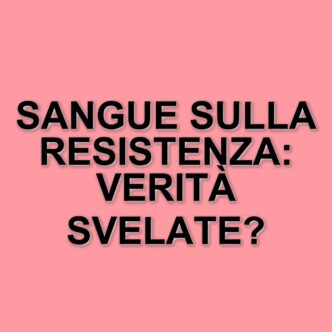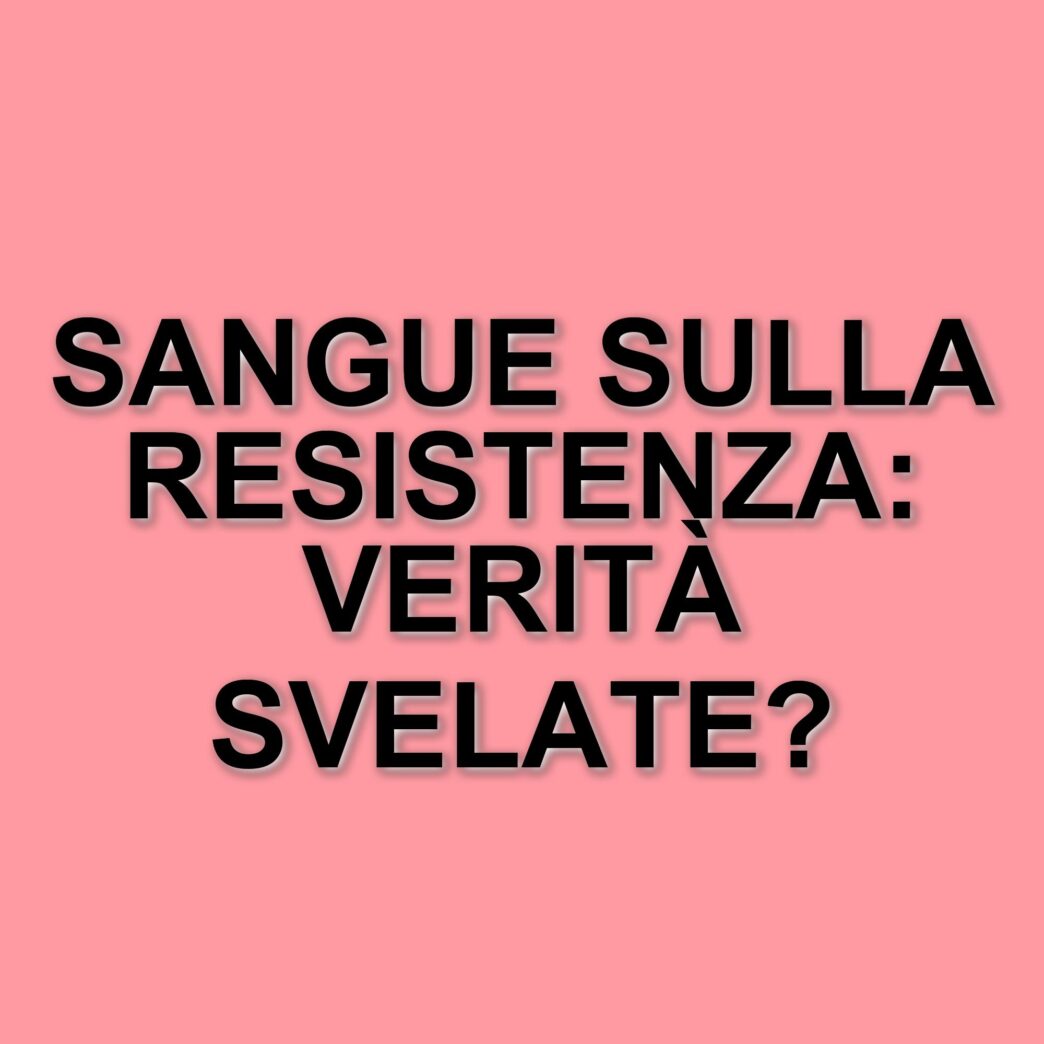L’ottantesimo anniversario della Liberazione offre l’opportunità di riflettere su eventi storici spesso trascurati, come l’eccidio di Porzûs. Questo tragico episodio, avvenuto nel 1945, è al centro del nuovo libro di Tommaso Piffer, “Sangue sulla Resistenza. Storia dell’eccidio di Porzûs”, pubblicato da Mondadori nel 2025. Le vittime di questa strage appartenevano alla Brigata Osoppo, un gruppo di partigiani azionisti e cattolici che si opposero all’occupazione jugoslava dei territori italiani, subendo un attacco mortale da parte di comunisti italiani affiliati ai Gruppi di azione patriottica .
La strage di Porzûs: contesto e dinamiche
L’eccidio di Porzûs si colloca in un periodo di intensa conflittualità all’interno del movimento di Resistenza. Le tensioni tra diverse fazioni politiche, in particolare tra comunisti e partigiani della Brigata Osoppo, hanno portato a una serie di scontri violenti. I partigiani della Osoppo, che si opponevano all’influenza jugoslava, furono attaccati nel febbraio 1945, culminando in un massacro che ha lasciato un segno indelebile nella memoria storica italiana.
Tommaso Piffer, nel suo libro, analizza le ragioni dietro questo tragico evento, evidenziando come le divergenze ideologiche abbiano alimentato una vera e propria guerra civile all’interno dell’antifascismo. La Brigata Osoppo, composta da partigiani che si identificavano con valori azionisti e cattolici, rifiutava di sottomettersi al controllo jugoslavo, mentre i comunisti, sostenuti dall’Unione Sovietica, cercavano di espandere la loro influenza.
Leggi anche:
Interpretazioni storiche e conflitti ideologici
L’interpretazione di Claudio Pavone, espressa nel suo saggio del 1991 “Una guerra civile”, ha dominato il dibattito storico sulla Resistenza, delineando tre aspetti coesistenti: la lotta per l’indipendenza, la lotta per la libertà e la lotta di classe. Tuttavia, Piffer propone una visione alternativa, evidenziando le fratture interne al movimento di Resistenza. Non si tratta solo di una lotta tra fascismo e antifascismo, ma di conflitti tra italiani e sloveni, e tra comunismo e anticomunismo.
Questa complessità si riflette nel comportamento del Partito Comunista Italiano, che, secondo Piffer, ha condotto una Resistenza non patriottica, ma piuttosto orientata verso un’ideologia internazionalista. Le parole di Stalin, pronunciate durante una riunione del 1945, rivelano l’intento di espandere l’influenza sovietica, sottolineando che la guerra non si limitava alla sconfitta dei nazifascisti, ma mirava anche alla conquista del potere.
La tragedia di Porzûs e le sue conseguenze
L’eccidio di Porzûs rappresenta un momento cruciale nella storia della Resistenza italiana, evidenziando la brutalità dei conflitti interni. Le tensioni tra le diverse fazioni partigiane sfociarono in violenze che colpirono non solo i nemici nazifascisti, ma anche i compagni di lotta. Piffer documenta come i partigiani della Osoppo, già in difficoltà, siano stati progressivamente isolati e attaccati dai comunisti, culminando nella strage che ha portato alla morte di diciotto uomini.
Le direttive politiche del Partito Comunista, come quelle impartite da Togliatti, hanno ulteriormente aggravato la situazione, portando a una chiara volontà di eliminare la Brigata Osoppo. Questo episodio non solo ha segnato la fine di molte vite, ma ha anche lasciato un’eredità di divisione e conflitto che ha segnato la storia italiana.
Riflessioni sull’eredità di Porzûs
A ottant’anni dall’eccidio, la memoria di Porzûs continua a sollevare interrogativi. Giorgio Napolitano, in qualità di presidente della Repubblica, ha riconosciuto l’importanza di commemorare le vittime della Brigata Osoppo, evidenziando le radici ideologiche che hanno portato a questa tragedia. Tuttavia, Piffer avverte che molte verità rimangono ancora da scoprire, in particolare riguardo ai responsabili e alle motivazioni che hanno guidato le azioni dei partigiani comunisti.
La storia di Porzûs non è solo un capitolo oscuro della Resistenza, ma un monito sulle complessità e le contraddizioni di un periodo cruciale per l’Italia. La narrazione di Piffer invita a una riflessione profonda sulle dinamiche interne al movimento di liberazione e sulle conseguenze di una guerra civile che ha segnato profondamente il paese.