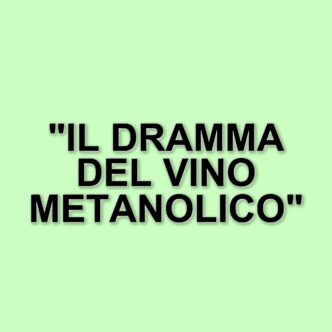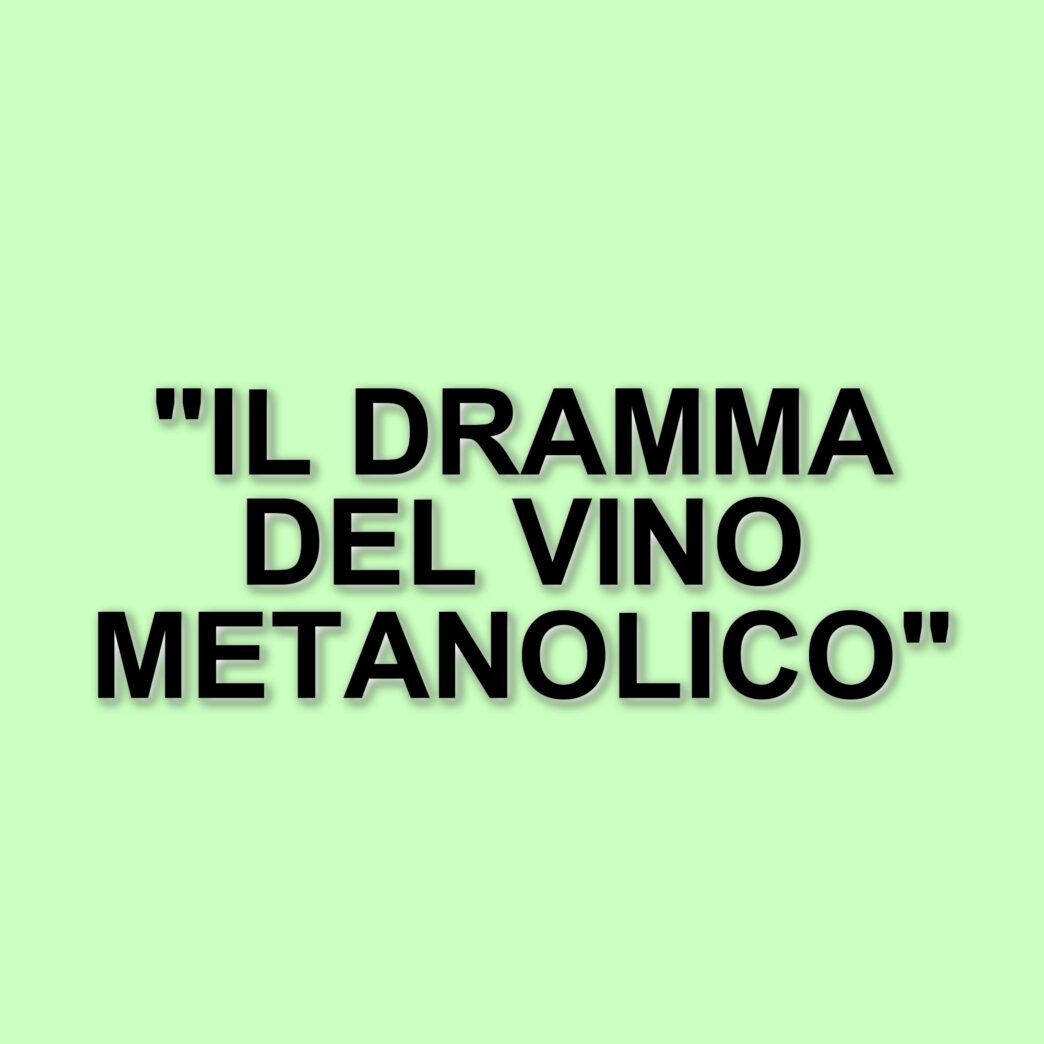Nel marzo del 1986, l’Italia fu scossa da una delle più gravi crisi sanitarie legate alla sofisticazione alimentare. La morte di due uomini a Milano, Armando Bisogni e Renzo Cappelletti, segnò l’inizio di un incubo che avrebbe portato a 19 decessi e a centinaia di intossicazioni. Questo articolo esplora gli eventi che hanno portato alla scoperta di un sistema criminale di adulterazione del vino e le conseguenze devastanti che ne sono derivate.
I primi decessi e l’emergere del problema
Armando Bisogni, 48 anni, fu trovato morto nella sua abitazione a Milano il 3 marzo 1986, accanto a un bottiglione di Barbera da due litri. Solo due giorni dopo, Renzo Cappelletti, 56 anni, di Paderno Dugnano, morì anch’egli nella sua casa, dopo aver bevuto lo stesso vino. Inizialmente, le cause di morte furono attribuite a infarto o a cause sconosciute. Tuttavia, la situazione cambiò rapidamente quando il 6 marzo, Valeria Zardini, 60 anni, si presentò all’ospedale Sacco di Milano con sintomi gravi dopo aver bevuto lo stesso vino. I medici, allarmati, iniziarono a sospettare di avvelenamento, ma la causa rimaneva ignota.
Il 12 marzo, la situazione si aggravò ulteriormente. Benito Casetto e Alvaro Antinori, entrambi con sintomi simili, furono ricoverati all’ospedale Niguarda. La dottoressa Franca Davanzo, presente al Centro antiveleni, identificò i sintomi come avvelenamento da metanolo, una sostanza altamente tossica. Le analisi sui vini portati dai pazienti rivelarono livelli di metanolo tra 2 e 10 millilitri per 100 ml, ben oltre il limite legale. Questo scoprì un sistema di sofisticazione alimentare che avrebbe avuto conseguenze devastanti.
Leggi anche:
L’allerta sanitaria e le indagini
La notizia dell’avvelenamento da metanolo si diffuse rapidamente. Il 18 marzo, il Corriere della Sera riportò la prima notizia di tre morti a Milano per vino sofisticato. Le indagini si intensificarono e i Nas iniziarono a sequestrare partite di vino contaminate in tutto il Nord Italia. I primi sospettati furono Vincenzo e Carlo Odore, imbottigliatori di Incisa Scapaccino, che si rivelarono innocenti. Nel frattempo, si scoprì che alcuni produttori avevano versato vino al metanolo nei fiumi per distruggere le prove.
Le indagini rivelarono che il metanolo era stato aggiunto deliberatamente a vini di bassa qualità per aumentarne il contenuto alcolico. Questo metodo, utilizzato da una banda di sofisticatori, aveva portato a una crisi di fiducia nel mercato vinicolo italiano. Le autorità iniziarono a comprendere che si trattava di un piano criminale ben orchestrato, con l’obiettivo di massimizzare i profitti a scapito della salute pubblica.
Il sistema criminale e le conseguenze sul mercato
Le indagini rivelarono che il metanolo era stato utilizzato come sostituto economico dello zucchero per correggere il vino. Questo sistema, avviato nel dicembre 1985, portò a un aumento esponenziale delle vendite di vino adulterato. Con il diffondersi dello scandalo, il mercato vinicolo italiano subì un duro colpo. Le esportazioni crollarono e la reputazione del vino italiano fu gravemente compromessa.
Il 1991 segnò l’inizio del processo contro i responsabili. Settembre di quell’anno vide l’arresto di sette persone, tra cui Giovanni e Daniele Ciravegna, accusati di aver sbagliato il dosaggio di metanolo. Le pene inflitte furono severe, ma molti dei colpevoli rimasero nullatenenti, lasciando le vittime senza risarcimenti. La tragedia del metanolo non solo causò morti, ma portò anche a una crisi economica nel settore vinicolo, con perdite stimate in mille miliardi di lire.
Riflessioni sul passato e cambiamenti nel settore vinicolo
Il disastro del metanolo ha radici più profonde, legate a una crisi del vino italiano iniziata negli anni Sessanta. Secondo Attilio Scienza, esperto di viticoltura, la fine della mezzadria portò a un abbandono delle tradizioni vinicole, con conseguente produzione di vini di bassa qualità. La crisi del metanolo ha portato a un cambiamento radicale nel settore, con un aumento dei controlli e una maggiore responsabilità da parte dei produttori.
Oggi, il vino italiano è considerato un alimento e non solo una bevanda. I produttori si concentrano sulla qualità delle uve e sulla sostenibilità, cercando di ripristinare la fiducia dei consumatori. La lezione appresa dal disastro del metanolo ha portato a un miglioramento generale del settore, con un’attenzione crescente alla salute e alla qualità del prodotto.