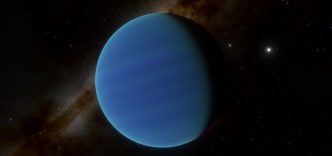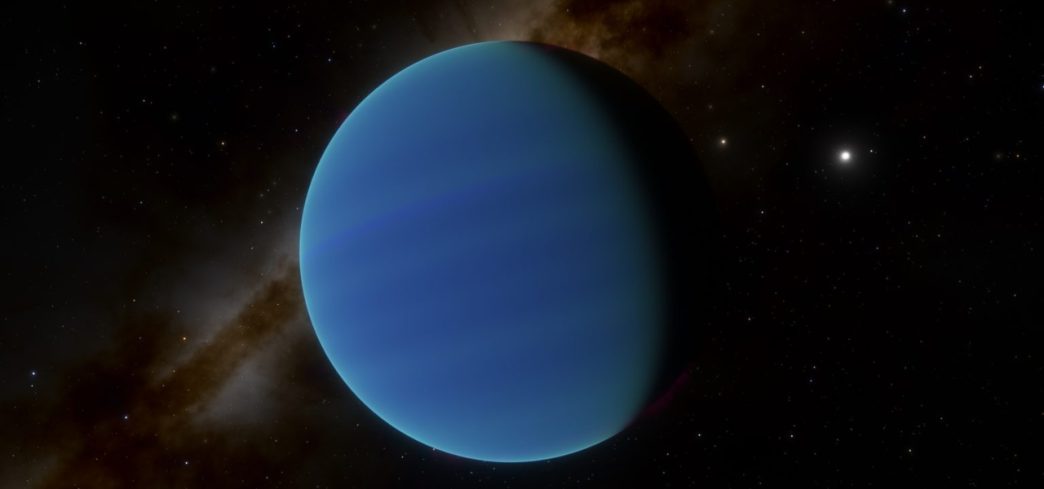La ricerca sugli esopianeti, mondi fuori dal sistema solare, ha compiuto trent’anni dalla prima scoperta ufficiale. Quel primo ritrovamento, annunciato nel 1995 da Michel Mayor e Didier Queloz, ha segnato l’inizio di una lunga serie di studi che hanno rivoluzionato la nostra conoscenza dei pianeti. Oggi sono quasi seimila quelli confermati, con caratteristiche e composizioni molto diverse tra loro. L’analisi del sistema kepler-10, uno dei più studiati, ha permesso di approfondire la natura di pianeti rocciosi e di quelli ricchi di acqua, rivelando fenomeni che sfidano le teorie tradizionali sulla formazione planetaria.
La scoperta del primo esopianeta e l’avvio della caccia nello spazio
Nel 1995, gli astrofisici Michel Mayor e Didier Queloz rilevarono un pianeta extrasolare che orbitava attorno a una stella analoga al Sole, un evento senza precedenti per la scienza astronomica. La tecnica usata, basata sull’osservazione delle variazioni nella velocità radiale della stella causate dalla gravità del pianeta, aprì nuove strade nella ricerca di corpi celesti al di fuori del sistema solare. Il premio nobel assegnato ai due ricercatori nel 2019 ha confermato il valore di quella scoperta.
Da allora, sono stati sviluppati strumenti sofisticati, sia da terra sia nello spazio, che hanno incrementato la capacità di individuare esopianeti. Il numero delle conferme si è spinto fino a quasi 6000, una quantità che ha svelato una grande varietà di corpi con orbite, dimensioni e composizioni differenti. Questo ampliamento delle conoscenze ha portato a rivedere i modelli classici di formazione e evoluzione planetaria, perché molti esopianeti mostrano caratteristiche che non si adattavano ai precedenti schemi teorici.
Leggi anche:
Il sistema kepler-10: caratteristiche e scoperta dei pianeti
Il sistema kepler-10 è diventato un punto di riferimento negli studi sugli esopianeti dal momento in cui il telescopio spaziale della NASA Kepler lo ha osservato circa quindici anni fa. Attraverso il metodo del transito, che misura la diminuzione periodica della luce stellare quando un pianeta passa davanti alla stella, sono stati identificati almeno due pianeti principali.
Kepler-10b è una super-Terra rocciosa con un raggio pari a 1,5 volte quello terrestre e un periodo orbitale di appena 20 ore, il che significa che completa la sua orbita in meno di un giorno terrestre. Kepler-10c, invece, è un sub-Nettuno con un raggio di 2,3 volte la Terra e un periodo di circa 45 giorni. Questi dati sono stati acquisiti grazie alle campagne di osservazione con lo spettrografo Harps-N, collocato al telescopio Galileo sull’isola di La Palma. Misurazioni di precisione sul moto radiale della stella, create dall’attrazione gravitazionale dei pianeti, hanno permesso di calcolare con precisione le masse di entrambi i corpi.
Composizione e natura dei pianeti kepler-10b e kepler-10c
Dalle analisi dettagliate è emerso che kepler-10b ha una struttura prevalentemente rocciosa, confermando la sua natura simile a quella dei pianeti terrestri. Kepler-10c, invece, mostra caratteristiche molto diverse; gli studi suggeriscono che si tratti di un water world, un pianeta con gran parte della massa costituita da acqua. Secondo i dati, tra il 40 e il 70% della sua massa sarebbe acqua, probabilmente racchiusa in un nucleo roccioso, un mantello di ghiaccio ad alta pressione chiamato ghiaccio di acqua VII, e un’atmosfera densa di vapore.
La temperatura sulla superficie di kepler-10c si aggira intorno ai 300 gradi centigradi, temperatura che rende improbabile la presenza di forme di vita come la conosciamo. Tuttavia, la presenza di acqua allo stato liquido o in stato super-critico tra ghiaccio e vapor, indica fenomeni fisici complessi che meritano attenzione soprattutto dal punto di vista planetario e chimico.
Il ruolo del terzo pianeta kepler-10d e la sua importanza
Nel sistema kepler-10 è stato individuato anche un terzo pianeta, kepler-10d, con un periodo orbitale di circa 151 giorni. La sua esistenza è stata dedotta da sottili variazioni orbitali nel moto di kepler-10c, ma, non essendo stato osservato in transito, non è possibile determinarne dimensioni precise o composizione.
Questo pianeta potrebbe rappresentare un importante anello di congiunzione tra gli altri due, fornendo spunti per comprendere meglio le dinamiche interne del sistema e le migrazioni orbitali avvenute nel tempo. L’analisi di tali sistemi multipli aiuta a chiarire come interagiscono pianeti con caratteristiche molto diverse nello stesso ambiente stellare.
Perché studiare i water world cambia il modo di vedere la formazione planetaria
L’esistenza di pianeti ricchi d’acqua come kepler-10c ricorda previsioni fatte dai modelli teorici di formazione planetaria. Questi mondi, nati lontano dalle loro stelle, oltre due o tre volte la distanza della Terra dal Sole, avrebbero accumulato grandi quantità di ghiaccio. Successivamente avrebbero migrato verso l’interno del sistema, avvicinandosi alla stella.
Il movimento di questi pianeti oceano può influire pesantemente sulla formazione di pianeti terrestri abitabili nelle zone interne del sistema. Inoltre, piano piano sta aumentando l’interesse per la possibile presenza di forme di vita, seppure elementari, su pianeti di questo tipo che si trovano in fasce dove le temperature permettono condizioni più favorevoli. Tuttavia, queste ipotesi restano da confermare con ulteriori analisi e osservazioni, soprattutto tramite lo studio delle atmosfere di tali pianeti con telescopi come il James Webb.
La ricerca intorno agli esopianeti si conferma, in questo senso, un campo fecondo dove ogni nuova scoperta introduce quesiti nuovi sulla natura dell’universo e sulle possibilità abitative al di fuori del sistema solare.